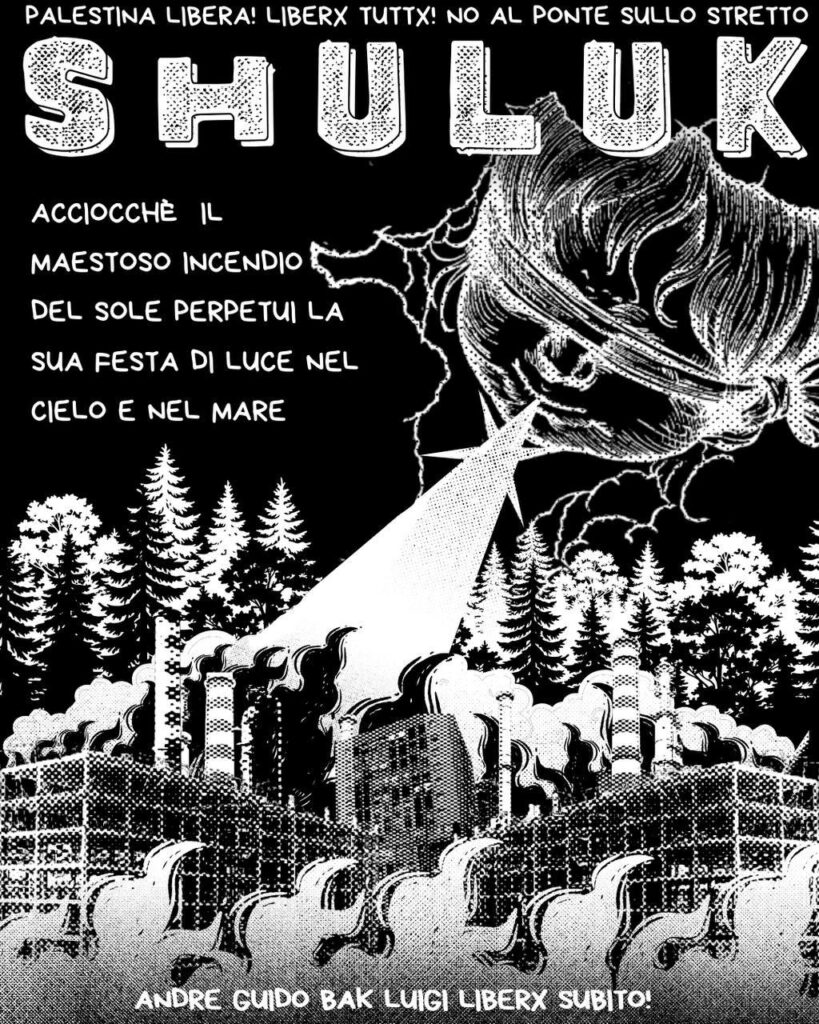Diffondiamo da Infranero:
In ogni caso, i fatti sono noti. Ripeterli, magari aumentando la dose dei relativi dettagli tecnici, non porta a nulla. Non si provocano né attacchi di panico né esplosioni di rabbia, e non si percepiscono chiare tracce di ansia. La popolazione civilitica è per lo più indifferente a quanto le accade davanti agli occhi — crede ancora di vivere in un mondo che non c’è più. Un mondo stabile e affidabile con le sue quattro stagioni, gli scaffali dei supermercati ben forniti, le vacanze prenotabili online, gli ambiziosi progetti di carriera, la meritata pensione dopo una più o meno dura vita di lavoro, e le soluzioni tecniche per eventuali imprevisti a portata di mano.
Una compostezza a prova di calamità. Alluvioni. Fiumi secchi. Ondate di calore. Tempeste. Incendi boschivi. Scioglimento di ghiacciai. Carestia dei raccolti. Estinzione di specie animali. Tutto continua come prima. Pandemia. Lockdown. Museruole ad hoc. Vaccinazioni dietro ricatto. Guerra. Genocidio. Sì, una seccatura, ma alla fine andrà tutto bene.
Eppure ormai dovrebbe essere chiaro: non esiste una catastrofe imminente, poiché siamo già dentro alla catastrofe. Evocare cupi scenari futuri è del tutto ridicolo e superfluo, il cupo presente è più che sufficiente. Sufficiente? Per stimolare cosa? Duemila anni di religione sacra che preannuncia il paradiso dopo la fine della vita, e duecento anni di religione profana che promette il comunismo dopo la fine del capitalismo, hanno ottenuto il loro migliore effetto: l’attesa. Perenne e fiduciosa. Davanti al susseguirsi delle catastrofi planetarie, l’umore generale è semplicemente passato dall’ottimismo forzato alla paralisi, in un micidiale miscuglio di rassegnazione e confusione. Di tutte le minacce, è questa la più immediata: la ragione è in ritardo rispetto alla realtà, motivo per cui azioni sostitutive si affollano nello spazio intermedio.
Bisogna infatti ammettere che la mente si trova oggi a confrontarsi con condizioni senza precedenti. È impossibile riflettere sulla nuova realtà senza affrontare contemporaneamente la questione di come questa influenzi il pensiero. Per quanto diversi possano essere i pericoli che incombono su tutti noi, hanno almeno un elemento in comune: sono generati dall’essere umano. Ciò significa che bisogna considerare anche il palese fallimento del pensiero.
Già solo la scelta dei vocaboli da usare pone non pochi problemi. È possibile parlare di cose sproporzionate senza utilizzare parole sproporzionate? Catastrofe? Apocalisse? Beh, di certo non si può parlare di crisi o di disastri. L’uso di questi termini, in relazione ai processi globali in corso, è già di per sé una banalizzazione. Se le parole sono importanti, allora vocaboli come crisi e disastri andrebbero tralasciati. Una crisi petrolifera o una crisi finanziaria, ad esempio, vengono percepite come manifestazioni acute di contraddizioni strutturali (dipendenza da una materia prima, movimento del capitale economico). Resta in piedi l’idea che si tratti tutt’al più di una risolvibile interruzione di un sistema altrimenti funzionante. Lo stesso vale per i disastri. Quando si verifica un’alluvione o un incendio boschivo, vengono prese misure di salvataggio, ma non appena l’emergenza non è più pressante la vita quotidiana torna a scorrere come prima. Perché il dis-astro è una disgrazia originata da una cattiva stella, da un destino avverso. Shit happens, dicono gli anglosassoni.
Sebbene meno rassicuranti, termini come collasso o rovina sono a loro volta fin troppo deterministici. In essi, la conclusione è già prestabilita; non c’è spazio per percorsi alternativi. Ma allora, se il destino è già segnato, perché rifletterci sopra e scriverne (per non parlare del perché agire al fine di influenzarlo)? Al contrario, un termine come antropocene alimenta l’illusione di una transizione verso un’èra moderna stabile e sicura. Un ottimismo davvero fuori luogo, che può solo spingere le case automobilistiche a progettare Suv ecosostenibili o i partiti ecologisti a sostituirsi alle redini del governo. Tutto sommato, nessuna di queste caratterizzazioni della situazione attuale è realmente utile. Piuttosto, sono rivelatrici di chi le utilizza.
Ammettiamolo. Da quanti anni siamo tutti consapevoli di viaggiare su un treno diretto ad alta velocità verso il baratro? Da quanti anni vengono lanciati appelli urgenti richiamando l’attenzione sul fatto che all’umanità resta pochissimo tempo per affrontare gli sviluppi allarmanti che minacciano la sua sopravvivenza? Quante volte sono stati ricordati i rischi del riscaldamento globale, dell’estinzione delle specie, del declino delle acque dolci, delle crescenti zone morte negli oceani, della progressiva deforestazione? Quante volte sono state denunciate, in un contesto simile, le crescenti possibilità della diffusione di virus letali? Oppure, quante volte il conflitto nel Donbass è stato annunciato come la scintilla che avrebbe provocato la terza guerra mondiale?
Eppure, non solo non è stato fatto nulla per scongiurarla, ma la situazione è peggiorata ulteriormente in tutti i settori. Cento anni fa, un singolo terribile avvertimento da parte di eminenti studiosi avrebbe gettato il mondo intero nello sgomento, persino nel panico, e non sarebbe stato privo di conseguenze pratiche. Oggi, vale a malapena una breve notizia.
Cos’è successo? Come nella famosa parabola della rana bollita, la maggior parte delle persone sembrano intorpidite dal graduale riscaldamento nella pentola e dalle ripetute notizie che ne derivano. Tutti sono informati, ma nessuno si sente veramente minacciato. Manca poco tempo, sì, sì, lo sappiamo già, non annoiateci. Anche la maniera in cui vengono date tali informazioni contribuisce alla fatale assuefazione. L’imminente apocalisse diventa una notizia da collocare tra un resoconto politico quotidiano e un reality show. Non che le si conceda troppo poco spazio, ci sono servizi su servizi e trasmissioni speciali sull’argomento. Semplicemente questa minaccia immanente è stata trasformata in un «argomento» a sé stante. Cinque minuti di apocalisse, ed ora passiamo allo sport. Come se il peso di quanto sta accadendo non gravasse su tutte le emozioni, i pensieri, i sogni, i progetti umani. La separazione tra catastrofe e vita quotidiana viene mantenuta artificialmente. In questo modo non è solo la catastrofe a venir resa irreale, ma anche e soprattutto la vita quotidiana.
Da qui, la paralisi. Indubbiamente, la ragione di questa paralisi prolungata è un peso immenso e soverchiante. Non è solo l’immaginazione a cedere di fronte alla catastrofe; le dimensioni di quanto sta avvenendo sono troppo smisurate per essere comprese. Il pianeta, l’umanità, la vita: come possono questi concetti non essere irrimediabilmente astratti in relazione alla nostra esistenza, che è pur sempre individuale? Quando gli scienziati si rivolgono «all’umanità», quando i movimenti si rivolgono al «popolo» o al «proletariato», i loro appelli vengono restituiti con la dicitura «destinatario sconosciuto». Ecco allora affiorare l’ovvia tentazione: non sarebbe più saggio smettere di rimuginare su questioni su cui ci si sente impotenti? Beati coloro che hanno un’immaginazione limitata, che senso ha torturarsi? Meglio dedicarsi a progetti concreti che consentano almeno piccoli miglioramenti, magari pompandoli di confortante retorica (dall’ambulatorio popolare all’orto insorto). Invidiabili sono i nostri antenati, a cui era permesso distruggere il proprio ambiente senza troppi rimorsi!
La scelta tra ignoranza e infelicità è un vecchio argomento filosofico e letterario, solo che a noi questa scelta non è più concessa. Tutti sappiamo. E quando ormai c’è la conoscenza, l’unica alternativa possibile al pensiero è la negazione o la rimozione. Ma come è noto, i fatti negati o rimossi non scompaiono affatto. Continuano ad operare. Sul tavolo anatomico dell’accademia, docenti e ricercatori possono ben continuare a sezionare il marxismo, annunciando di aver rinvenuto in esso frammenti primordiali di un pensiero critico. Nelle piazze reali o virtuali delle metropoli, attivisti e militanti possono ben continuare ad agitarsi e ad esaltarsi per il movimento sociale del momento, annunciando di intravedervi la possibilità concreta di sfidare l’ordine delle cose. Non sono che narrazioni autoconsolatorie davanti a una realtà sempre più atroce.
Meglio non dirlo, giusto? In un’epoca in cui persino una tiepida giornata di aprile non può essere goduta senza provare un malessere di fondo, in un’epoca in cui le forze dell’oscurantismo emergono sotto le spoglie dell’illuminismo, in un’epoca che viene tranquillamente definita dai suoi stessi cronisti «era pre-bellica», la minima riserva critica ha tutte le probabilità d’essere considerata un affronto intollerabile. Una passione triste che guasta la riscossione di interessi allegri. Ecco perché chiunque venga percepito come pessimista rischia di essere messo alla gogna. Ma se ieri un ironico Günther Anders preoccupato per la guerra fredda precisava ai suoi detrattori che «pessimista è un termine fin troppo ottimista», noi che oggi siamo alle prese con tutte queste guerre bollenti cosa dovremmo dire?
Ciò che è accaduto negli ultimi cinque anni ha terminato di annientare il mondo così come l’abbiamo conosciuto, quello in cui siamo nati e cresciuti, fino ai resti delle sue illusioni. Ognuno ha visto sbriciolare i propri abituali punti di riferimento; chi lo stato di diritto, chi il potere al popolo, chi il risveglio delle coscienze… pilastri ridotti in polvere e macerie dalla tracotanza del dominio e dall’implacabilità dei suoi algoritmi. In un simile contesto si può fingere di vivere ancora nel Novecento e nel suo immediato prolungamento, alimentandone all’infinito le speranze. Oppure si può prendere infine atto di essere alieni in un territorio perennemente straniero e ostile. Se l’orrore per l’immane tracollo dell’intera civiltà, la rabbia di fronte alle devastanti conseguenze, la testardaggine di non volerle subire passivamente, non portano necessariamente né all’ottimismo beota né al pessimismo impotente, vero è che un minimo di lucidità — «la ferita più vicina al sole» — è oggi più che mai un requisito indispensabile per riconoscere e giocarsi le possibilità residue, quali che siano.