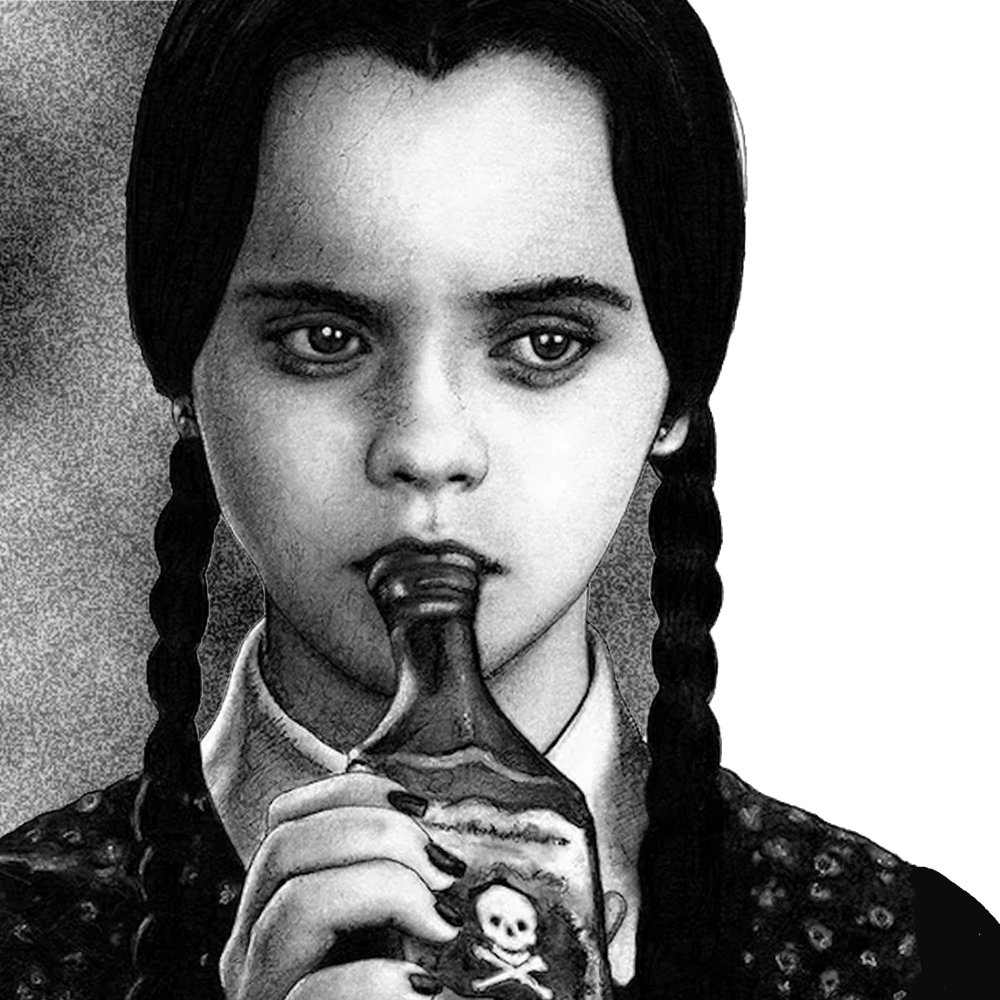
Riceviamo e diffondiamo:
Questo testo è stato inizialmente pubblicato sul n° 2 della rivista Caligine primavera-estate 2021 ed è stato pensato come una risposta all’articolo “Distinti saluti! Alcune riflessioni sul femminismo, sulle dinamiche di ammaestramento e sul tentativo di americanizzazione delle lotte” uscito sul Bollettino n. 4 della biblioteca dello Spazio Anarchico “Lunanera” di Cosenza. Decidiamo di dargli una nuova diffusione alla luce del recente dibattito scoppiato in rete perché crediamo contenga delle riflessioni ancora valide visto il contenuto espresso da alcuni testi recenti. L’articolo che segue è stato leggermente rimaneggiato rispetto alla pubblicazione originaria.
INTACCANDO L’ARROGANZA DEL PRIVILEGIO
“Nella società borghese, è normale sparlare delle persone alle spalle,
ma mai fare critiche costruttive in faccia; allo stesso tempo,
ognuno resiste sistematicamente all’ammettere
qualsivoglia errore commesso.”
David Gilbert
Amore e lotta
Autobiografia di un rivoluzionario negli Stati Uniti
Se mi spingo a scagliare un’altra pietra contro l’ennesima espressione dell’antifemminismo che si annida in seno all’anarchismo italiano non è certo per il piacere di inoltrarmi nel ginepraio velenoso che sembra diventato ultimamente il dibattito attorno a certi argomenti, nella speranza che un giorno le pietre raccoltesi nel tempo attorno al corpo morto del patriarcato possano costituire le fondamenta di un ponderare sovversivo scevro non solo dai suoi dannosi pregiudizi sessisti, ma anche da tutti quegli orpelli ideologici di cui è uso diffuso agghindare le sue vesti. Questi costituiscono dei veri e propri feticci attorno ai quali il pensiero gregario si raggruma rinnovando il culto alle peggiori espressioni della cultura dominante, quali sono, solo per citarne alcune delle più note e nocive, il dualismo (come separazione di teoria e pratica, mente-corpo, umano-natura, uomo-donna, etc.), il positivismo (inteso come fede nella ragione e nelle sue capacità di discernere una qualsiasi verità), il progressismo (ovvero quella visione della storia come un procedere verso un indiscusso miglioramento futuro).
Lungi da me il voler trattare così difficili e complessi argomenti in questa sede. Il mio contributo vorrebbe essere di ben più modesta portata. Né tanto meno ho intenzione di esprimermi su faccende strettamente femministe o che riguardano la reazione ad una violenza sessuale e sugli strumenti che ci si dà (o che, a piacere, si decide di non darsi) per affrontarla, né sui temi del consenso o dei modelli sessuali che determinano in qualche modo il desiderio. Sono stati già diffusi a questo proposito testi che dimostrano con abbastanza chiarezza la miseria di quella Reazione che appesta l’aria di questi tempi, così come la degna rabbia che è ormai sul costante punto di tracimare ad ogni suo nauseante sentore.
Da parte mia vorrei invece provare ad apportare qualche riflessione su di un tema particolarmente delicato eppure di estrema importanza per quell’anarchismo che prosegue interrogandosi attorno alla cornice epistemologica in cui sono inseriti i suoi tentativi di sovvertire il mondo del dominio: quello del recupero delle lotte da parte del potere, e della posizione di privilegio che è alla radice di un certo modo di concepire ed intendere quest’ultimo.
Credo di poter affermare, senza troppe precauzioni, che una delle caratteristiche di maggior forza che il sistema statale a sfondo democratico-capitalista ha saputo sapientemente sviluppare per sopravvivere è la capacità di recuperare a proprio favore quelle istanze di liberazione che di volta in volta ne mettono in discussione l’ordinamento. Questo elemento costituisce una differenza considerevole rispetto agli stati generalmente definiti autoritari o totalitari, che preferiscono censurare e reprimere duramente qualsiasi voce o gesto dissidente che si discosti dalla norma su cui essi si poggiano e che raramente sono predisposti a concedere alcunché alle insubordinazioni interne. E posso con forse ugual facilità evidenziare che ogni lotta vincente o sconfitta, non avendo raggiunto l’obiettivo del totale e inequivocabile abbattimento del potere, abbia in qualche modo contribuito a rinsaldarlo. Le istituzioni del potere infatti, mantenute intatte le proprie strutture, raccolgono quasi sempre con maggiore efficienza dei loro nemici la lezione tratta dalle peculiarità dello scontro avvenuto, riuscendo poi a utilizzarla a proprio vantaggio. Ne è un chiaro esempio l’evoluzione che costantemente attraversa gli apparati repressivi dal punto di vista giuridico, tecnologico, tattico e strategico. L’argine che gli stati hanno costruito per contrastare l’ondata ribelle degli anni ‘60 e ‘70, tanto per fare un esempio, fornisce ancora numerosi strumenti che la repressione continua ad utilizzare contro chi osa opporsi all’odierna pace sociale.
Ma non è altresì con altrettanta leggerezza che si può affermare che l’esprimersi di una istanza specifica di liberazione “rinforzi il capitalismo e la democrazia”, né in egual modo credo si possa additare le insufficienze teoriche del movimento rivoluzionario come la causa principale delle sue sconfitte. L’insufficienza dei mezzi (anche teorico-analitici) di cui ci si dota lanciandosi all’assalto del cielo si evince con difficoltà nella bolgia del conflitto, ma quasi sempre a posteriori, quando a bocce ferme si ricostruiscono i fattori che hanno stabilito l’esito dello scontro. Dal momento che i risultati di una lotta si determinano nella realtà degli elementi in gioco e la complessità della loro interazione ci impedisce di elaborare una previsione attendibile sullo sviluppo degli eventi è quantomeno presuntuoso pensare di possedere una corretta impostazione teorica che ci tiene al riparo dai rischi della sconfitta.
Storicamente parlando e semplificando all’estremo, il potere ha sempre risposto con un’attitudine repressiva alle esplosioni sociali che ciclicamente mettono in discussione una o più forme del suo operare. Accanto alla dura e cruda violenza è stata però spesso messa in campo una strategia di cooptazione che, attraverso diversi canali e livelli di mediazione, elargendo cariche, beni o privilegi, ha lo scopo di frammentare il fronte delle forze d’opposizione giocando sulle sue differenti disposizioni e condizioni interne. Le porzioni più radicali che rifiutano di adeguarsi alla ragion pratica del compromesso vengono così da principio individuate e isolate dal resto del corpo ribelle, e successivamente stroncate in maniera esemplare. Ogni sollevazione sociale produce infatti nelle circostanze dello scontro delle componenti che si spostano verso posizioni più inclini alla mediazione con le istituzioni del potere al fine di materializzare dei miglioramenti parziali, valorizzando, a seconda delle circostanze, il rapporto di forza raggiunto o altrimenti cercando di garantire la propria sopravvivenza, rinunciando di fatto alle proprie aspirazioni di liberazione totale. Ciò è avvenuto e avviene anche nel movimento anarchico (basti pensare alla Spagna del ‘36), e non c’è impianto teorico che tenga quando si entra nel vivo della violenza controinsurrezionale. Ed è fuori da ogni dubbio che queste tendenze siano utili allo Stato che le recupera per rafforzare la sua legittimità intaccata dalle lotte e indebolire i movimenti di opposizione interni; credo che possiamo facilmente convenirne.
Questa dinamica della repressione è ben riconoscibile nella storia conosciuta, dai tempi delle sommosse dei vari zek, schiavi e plebei contro i loro odiati padroni ed oppressori, passando per le rivolte millenariste e utopiste dei contadini che hanno infiammato l’Europa durante il Medioevo, ai vasti fronti proletari con aspirazioni rivoluzionarie dei secoli XVII, XVIII, XIX e della prima metà del secolo scorso, fino a quelli del contrasto ai movimenti e alla lotta armata nella storia più recente. La sproporzione delle forze in campo e l’astuzia del potere sono elementi che vanno tenuti a mente e soppesati con attenzione quando si vogliono valutare le cause di una sconfitta nei processi di liberazione, sconfitta che non si può imputare (a posteriori) con leggerezza ad una incorretta formulazione teorico-tattica, o alla recuperabilità delle rivendicazioni espresse. Si voglia, per puro amor della memoria storica e dal momento in cui l’argomento è stato di recente menzionato, ricordare ancora l’immensa mole di sforzi che gli stati hanno messo in atto solo nel periodo della contestazione degli anni ‘60 e ‘70. Negli Stati Uniti, la più grande potenza economica e militare del mondo contemporaneo, il movimento contro la guerra del Vietnam e le disuguaglianze, rapidamente evolutosi in movimento antimperialista e rivoluzionario (sintomo di un’approfondita analisi d’insieme sul funzionamento del capitalismo e dello Stato), si vide contrapporre un elevatissimo livello di violenza espresso da tutti gli apparati della repressione, che andò dalla sanguinosa repressione nelle strade e nei campus universitari di coloro che lottavano per l’autodeterminazione dei popoli, all’omicidio mirato e alla tortura delle individualità rivoluzionarie. Basti pensare agli interventi della polizia all’università di Berkeley nel ’64 (circa 800 arresti) e alla Kent State University nel ’70 (quattro morti da arma da fuoco), solo per citare due eventi famosi, o alle stragi dei gruppi militanti afroamericani, vittime di veri e propri agguati e spesso giustiziati sul posto nel corso dei raid delle forze repressive (come l’omicidio a sangue freddo di Fred Hampton, membro delle Pantere Nere, nel 1969). Le stesse tecniche contro-insurrezionali e di contro-guerriglia vennero poi usate anche in Italia e in Europa per contrastare il movimento e il diffondersi della lotta armata grazie alle collaborazioni sul campo all’interno del cosiddetto “blocco occidentale”.
È sintomatico di una qualsivoglia forma di organizzazione societaria che veda minare le fondamenta della propria legittimità aumentare l’uso della violenza per puro e semplice moto di autoconservazione, violenza che cresce in ferocia tanto più si senta messa alle strette. Essa è infatti l’espressione di persone fisiche che hanno paura quanto chiunque altro di perdere il potere che la propria posizione di privilegio gli fornisce all’interno di un determinato sistema di stratificazione sociale.
E’ in questo clima che il femminismo comincia a diffondersi nel movimento contro la guerra aiutandolo – assieme ai contributi analitici di quelle componenti sociali storicamente escluse dall’amministrazione del potere, come le persone non bianche o non eteronormate – ad ampliare il suo sguardo critico circa i rapporti all’interno della società capitalista e a spingere le sue rivendicazioni verso una più coerente e complessiva prospettiva anticapitalista e rivoluzionaria.
Credo quindi che sia alquanto semplicistico indicare il femminismo “storicamente dato” come complice del “rafforzamento della democrazia e del capitalismo” per sminuirlo, dal momento che questa istanza di liberazione oltre ad aver mobilitato un gran numero di donne nel mondo intero, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del funzionamento del potere nelle sue dinamiche più interiorizzate e normalizzate dagli individui che costituiscono il tessuto di una società. Né si può con tanta superficialità incolpare di questo rafforzamento le sue pratiche poiché, se è indubbiamente vero che una parte del movimento femminista ha agito e agisce in maniera riformista e giustizialista, esso ha dato espressione anche a pratiche ben più radicali, dalle azioni dirette contro negozi e aziende complici della mercificazione dei corpi delle donne, agli attacchi contro medici obiettori di coscienza e strutture sanitarie che effettuavano ricerche biotecnologiche, fino ad esperienze di lotta armata con prospettive rivoluzionarie. È perciò il recupero da parte del potere del femminismo a dover essere osteggiato, e non il femminismo in sé. Sottolineare, facendo un bilancio parziale di un movimento, soltanto il contributo che esso ha dato al rafforzamento del potere vorrebbe dire non riconoscere il valore di tutte quelle lotte che pur non avendo causato un sovvertimento del sistema di potere, hanno comunque comportato un reale miglioramento delle condizioni di vita per migliaia, spesso milioni, di individui, nonché all’arricchimento teorico e pratico del movimento rivoluzionario largamente inteso. La critica radicale anarchica osteggia ogni riformismo perché con esso si permette la perpetuazione della presente organizzazione dello sfruttamento, ma dovrebbe guardarsi dallo scadere in un idealismo elitarista e sprezzante.
Questo atteggiamento è già di per sé sintomo e ignara manifestazione del proprio intrinseco privilegio, basato su condizioni sociali come il benessere economico, la razzializzazione o il genere (e molto spesso, soprattutto quando vengono espressi giudizi tanto duri e trancianti sulle lotte altrui, di tutte queste messe assieme). Parlare di privilegio per l’anarchismo non è, come a volte si è tentato di insinuare, incentivare discorsi o atteggiamenti vittimistici o colpevolizzanti, ma un modo per chiarire il posizionamento preciso nella fitta rete dei rapporti di potere. Dalla propria posizione sociale infatti chiunque perpetua (se non agisce altrimenti) l’oppressione che il suo ruolo rappresenta all’interno di un dato ordinamento societario. Non tenerlo in considerazione porta a sviluppare una concezione assai parziale dei meccanismi di oppressione e di riproduzione del potere nelle società umane, troppo spesso individuati nelle sole istituzioni politiche ed economiche, e a fare di conseguenza una gerarchizzazione dei differenti fronti della guerra sociale. Questa attitudine è una chiara eredità di origine marxista, per la quale tra le diverse contraddizioni del divenire societario la principale a cui fare riferimento per sviluppare un processo rivoluzionario è quella di classe. Se per l’anarchismo la questione centrale è invece quella del potere, non dovremmo permettere alla comprensione delle sue molteplici espressioni di limitarsi alle sole configurazioni dello Stato e del Capitale, quanto considerarla nella sua accezione più intrinsecamente sociale che determina i rapporti quotidiani e le relazioni tra gli individui. Credo infatti che lo spargere sermoni dall’alto della propria posizione, ritenuta con arroganza essere la più coerente ed incisiva, rifletta l’autoritarismo insito in chi propende per una gerarchizzazione delle lotte, mentre un impegno a tutto campo dell’individuo nel contrasto ad ogni forma di potere sia ciò che più si avvicini ad un agire anarchico inteso come antitetico a quel “fare militante” largamente ereditato dalla cosiddetta sinistra rivoluzionaria.
L’assumere una posizione contro ogni rivendicazione parziale è sicuramente ciò che impedisce all’anarchismo di abbracciare una logica gradualista o di riforma del sistema di dominio, nonché di identificarsi completamente con movimenti quali sono quello femminista, ecologista, antispecista. Eppure essi hanno al loro interno espresso dei contenuti che assunti radicalmente comporterebbero le messa in discussione totale dell’attuale organizzazione dell’oppressione. Per questo “semplice” motivo le loro analisi sono state da tempo riconosciute come un contributo prezioso per i modelli di comprensione del funzionamento del potere nella nostra società, permettendo di abbandonare ogni retaggio che costituisca un limite per l’analisi anarchica. Le istanze di liberazione particolari dovrebbero quindi essere al centro della sensibilità anarchica, che rivendica la libera e completa espressione dell’individuo contro qualsiasi tentativo di vederlo relegare in secondo piano da una qualsivoglia priorità teorico-strategica. Esse non sono una riduzione, ma piuttosto un allargamento dello sguardo attraverso il quale si osserva e comprende il mondo. Una libera e completa espressione di sé che non deve essere confusa con quelle concezioni dell’individualismo figlie di una certa interpretazione superomista del pensiero nicciano che porta a giustificare la sopraffazione di un essere umano sull’altro e dell’essere umano sul mondo naturale in nome della sua inviolabile volontà di potenza. Concezioni queste che guarda caso furono fatte proprie dal nazismo e dal fascismo e che tanto bene si sposano con l’individualismo liberale per cui la competizione è la più alta forma di regolazione della vita. Questa maniera di concepire i rapporti tra individui ben si discosta dall’Unione degli Egoisti di cui parla Stirner (anarchicamente intesa) e dovrebbe essere rifiutata con forza da coloro che intendono riflettere su come costruire un rapportarsi vicendevole che rafforzi la lotta contro ogni potere. L’etica anarchica mette infatti al centro della sua riflessione la solidarietà tra gli oppressi attraverso il mutuo appoggio e di conseguenza dovrebbe perseguire il benessere dell’individuo che partecipa all’Unione per il vantaggio dell’Unione stessa. Indi per cui ragionare su come sovvertire le nostre relazioni è una pratica altamente rivoluzionaria perché permette di comprendere il potere come una forza che attraversa, imputridendola fin dalle radici, l’intera società e che coinvolge inevitabilmente anche i gruppi anarchici. È infatti dal riconoscimento delle diverse forme di potere che l’individuo può comprendere l’esperienza dell’oppressione che attanaglia sé stessx e i propri simili e decidere di intessere relazioni il più possibile libere nella comune volontà di secessione dalla società del dominio, oltre che di combattere anima e corpo contro questo mondo di sfruttamento e oppressione che lo incatena.
Credo che la teoria sovversiva non dovrebbe essere utilizzata per innalzarsi su di un pulpito dal quale spargere giudizi sprezzanti, così come la critica assuma una dubbia efficacia se armata di strumenti come la denigrazione o la calunnia al fine di tirare a lucido il proprio ego sovradimensionato. Teoria e critica radicale dovrebbero invece servirci per analizzare il presente e le lotte nell’ottica di rafforzare la guerra sociale, nella consapevolezza che non esiste formulazione teorico-strategica rivoluzionaria che possa condurci con certezza al trionfo e che è necessaria una costante riformulazione dei propri paradigmi per attizzare un conflitto sempre a rischio di soffocamento a causa delle dinamiche di recupero e di rigenerazione del potere. In quest’ottica sarebbe utile che un’analisi di questo tipo si sviluppasse in termini costruttivi sottolineando le proprie mancanze in quanto ad intervento sovversivo (mancanze che si continuano a registrare negli ambienti anarchici, sia a livello pratico che in quanto a comprensione del contingente storico), piuttosto che concentrarsi su quelle altrui con l’obiettivo di screditarne le posizioni in una sorta di competizione di radicalismo o, peggio, per attribuirgli la responsabilità dei propri continui fallimenti. Questi atteggiamenti e comportamenti invece di acuire il pensiero critico, a mio giudizio portano solo scoramento e disillusione. Invece di abbandonarsi ad essi sarebbe più lungimirante e utile investire le proprie energie nel contribuire a migliorare il dibattito con lo scopo di un innalzamento della qualità generale del conflitto sociale, considerando che se il potere un giorno cadrà non sarà con ogni probabilità grazie alla forza soverchiante di una “giusta” e corretta pratica o teoria radicale, ma per la somma dei singoli atti individuali di rivolta. Perciò ben venga la contaminazione e la sinergia delle lotte inserita in una comune ricerca dell’Anarchia piuttosto che qualsiasi forma di “celodurismo” e di purismo, di cui sarebbe bene cominciare a liberarsi in fretta, assieme a tutti gli altri residui di quella cultura machista militante che da troppo tempo ammorba ormai l’anarchismo.
